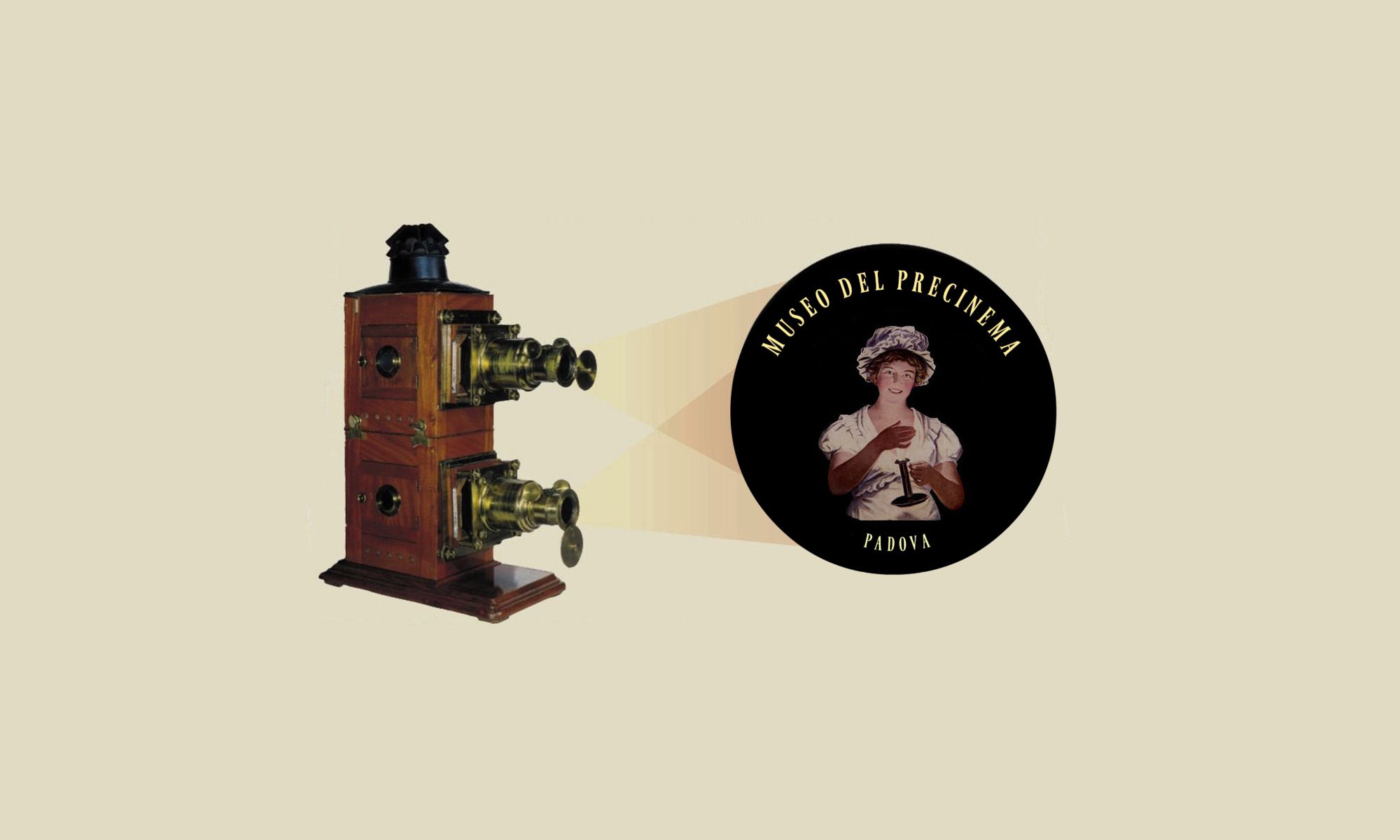Il Museo del Precinema di Padova rappresenta un unicum nel panorama dei musei non solo italiani, quasi una Wunderkammer (camera delle meraviglie); fondato da Laura Minici Zotti nel 1998 in collaborazione con il Comune di Padova e Assessorato alla Cultura e Turismo con la consulenza dell’Arch. Gianfranco Martinoni, grazie a un interessante progetto tra pubblico e privato. Ora il direttore del museo è il Prof. Carlo Alberto Zotti Minici, figlio della fondatrice, docente all’Università degli Studi di Padova (Storia del cinema, Storia e tecnica della fotografia).
Per individuare e capire meccanismi e percorsi che hanno portato alla nascita e diffusione, sul piano mondiale, di una nuova “specie umana”, quella dell’uomo visionario, partendo dall’invenzione dei Fratelli Lumière è necessario procedere a ritroso lungo un arco di vari secoli. E’ importante mantenere al centro del fuoco dell’osservazione sia la storia delle macchine della visione – già in parte conosciuta ed esplorata – quanto quella, più vasta e dai confini incerti, della visione popolare e delle forme di spettacolo ottico che, nel corso dei secoli, hanno condotto all’invenzione del Cinema.
 Prato della Valle. Fotografia di Antonio Cesaro ©
Prato della Valle. Fotografia di Antonio Cesaro ©
Il monumentale quattrocentesco Palazzo Angeli, di proprietà del Comune di Padova, situato in Prato della Valle, nel centro storico della città, costituisce la sede più appropriata per custodire ed esporre tali strumenti e vetri da proiezione, dipinti a mano originali del ‘700 e dell‘800. Si possono inoltre ammirare: il “Mondo niovo” con le vedute ottiche, una raccolta di strumenti e giochi ottici che per tutto l’800 e particolarmente in età vittoriana, testimoniano in maniera multiforme l’esigenza di uscire dall’impasse dell’immagine fissa e unidimensionale.

Dal 2018, a catturare l’attenzione dei visitatori nella prima sala con il suo monumentale splendore, è l’antico Mondo Novo della nobile famiglia Dolfin di Venezia. Raffinato prodotto di arte lignea della fine del Settecento, ha le sembianze di un teatro, decorato sia all’esterno, in perfetto stile neoclassico, sia nella sua parte interna, dove viene riprodotto in miniatura un palcoscenico arricchito di stucchi e un pavimento finemente cesellato. Arrivato in Museo grazie alla gentile concessione delle famiglie Cantele e Pedrotti, eredi della nobile casata, rappresenta uno dei più straordinari esempi di pantoscopio esistenti al mondo, e grazie a un attento restauro, è possibile ammirarlo in funzione.Accanto a semplici congegni a carattere giocoso come i taumatropi, o le anamorfosi appaiono strumenti più ingegnosi come il fenachistoscopio, il praxinoscopio e lo zootropio.
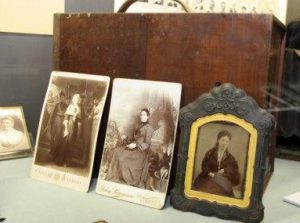 Una sezione è dedicata alla fotografia dove è possibile osservare le immagini inserite nel megaletoscopio “privilegiato” di Carlo Ponti del 1864; per continuare con la stereoscopia dove si trovano stereoscopi d’epoca, portatili o a colonna corredati di immagini fotografiche che appaiono tridimensionali.
Una sezione è dedicata alla fotografia dove è possibile osservare le immagini inserite nel megaletoscopio “privilegiato” di Carlo Ponti del 1864; per continuare con la stereoscopia dove si trovano stereoscopi d’epoca, portatili o a colonna corredati di immagini fotografiche che appaiono tridimensionali.
 Lanterna Magica Pettibone, Ohio 1880 ca.
Lanterna Magica Pettibone, Ohio 1880 ca.Fiore all’occhiello di questo museo sono le lanterne magiche che hanno documentato, con le loro proiezioni, l’affascinante viaggio dell’immagine proiettata, dal Settecento alla nascita del Cinema. Tra i pezzi più pregiati, oltre alle lanterne da proiezione, singole, le Fantasmagoria lanterns, la lanterna doppia di W. Tyler, la lanterna tripla di J. H. Steward, in mogano con obiettivi in ottone, databili attorno al 1880 ca.; la lanterna scientifica della P. Harris & Co., la lanterna “The Pettibone” di produzione americana, altre antiche lanterne appaiate e per finire la lanterna – cinema di Walter Gibbons.
Una bacheca è riservata alle lanternine giocattolo in latta verniciata con decorazioni a sbalzo di Lapierre, Plank o Müller, oltre alle coloratissime lanterne salon di produzione francese.
Accanto agli apparecchi da proiezione, la Collezione Minici Zotti, raccoglie migliaia di vetri databili tra la metà del XVIII secolo e gli inizi del XX secolo. Sono per la maggior parte dipinti a mano, oppure incisioni riportate su vetro o fotografie colorate a mano, oltre agli interessanti vetri “a movimento” con i quali ottenere divertenti animazioni; tra questi i cromatropi, il famoso coreutoscopio a banda e le dissolvenze con effetto giorno-notte.
Non mancano gli antichi strumenti musicali, un teatro d’ombre javanesi di fine ‘800 e la ricostruzione della camera oscura.
 Ghironda, Francia 1870 ca.
Ghironda, Francia 1870 ca.
Spettacoli di Lanterna Magica
Vetro per Lanterna Magica, fotografia colorata a mano, Inghilterra, 1890 ca.
Laura Minici Zotti, fondatrice del Museo, ma anche abile lanternista, ha divulgato la conoscenza delle rappresentazioni con la lanterna magica, iniziando nel 1975, davanti alle platee sparse in buona parte del mondo, adoperando una lanterna magica di J. H. Steward a doppio obiettivo del 1880, unitamente ai vetri (cm. 8×8) dipinti a mano nell’800, spesso animati da piccoli meccanismi. Nel dicembre 2007, a Laura Minici Zotti è stato conferito il Sigillo della Città di Padova e nel 2008 alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, il prestigioso premio Jean Mitry per il costante impegno culturale e la diffusione del Precinema. Inoltre nel 2010 Premio Donna Eccellente per la cultura e il Premio Vittorio De Sica, consegnato al Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
 Cromatropio per Lanterna magica, meccanismo a movimento, Inghilterra, 1880 ca.
Cromatropio per Lanterna magica, meccanismo a movimento, Inghilterra, 1880 ca.
Il 7 Ottobre 2010 al Teatro Verdi di Pordenone, durante la XXIX edizione delle “Giornate del Cinema Muto”, la lanternista si è esibita per l’ultima volta. Forse una delle rappresentazioni più emozionanti dove la luce della lanterna si è spenta su un pubblico commosso in standing ovation. Un grande successo che non ha convinto Laura Minici Zotti a cambiare idea, nelle sue rappresentazioni ha sempre usato vetri e lanterna magica originali. Questo comportava un rischio di degrado del colore dei vetri, che sarebbe aumentato inesorabilmente continuando con la loro proiezione.
La dott.ssa Minici Zotti è impegnata ancora oggi nel proporre unicamente le conferenze in Power-Point.
Alcune prestigiose sedi che hanno ospitato le rappresentazioni con la Lanterna Magica di Laura Minici Zotti:
1975 LUCCA: 11° Salone Internazionale del Comics e Cinema di Animazione, Teatro del Giglio
1976 ASOLO: Festival del Cinema sull’Arte e Biografie d’Artisti, Teatro Duse
1981 VENEZIA: Viaggio dei Comici italiani nel ‘700 in Europa, Palazzo Grassi
1985 FIESOLE: Serata in onore di E. Scola, Abbazia
1985 PERGINE: Festival Pergine Spettacolo Aperto, Castello di Pergine
1985 ESPINHO: Festival Cinanima
1985 VENEZIA: XLII Mostra del Cinema, Sala Pasinetti
1985 MILANO: Museo della Scienza e della Tecnica
1985 PORDENONE: Le Giornate del Cinema Muto, Teatro Verdi
1985 PRAGA: Ambasciata d’Italia
1985 BOLZANO: 90 anni del Cinema, Teatro Comunale
1986 LONDON: Convention of Magic Lantern Society
1986 FIRENZE: Festival Ragazzi&Cinema, Teatro Le Laudi
1986 GENOVA: 90 anni del Cinema a Genova, Cinema Palazzo
1986 ZAGREB: Festival Hall Cinema di Animazione
1986 GIJON: Festival de la Juventud, Cine Holliwood3
1987 LAON: Festival Jeune Public
1987 PISA: Biennale del Cinema dei Ragazzi
1987 MADRID: Ambasciata d’Italia
1987 FRANKFURT: Filmuseum
1987 KASSEL: Documenta Film Festival
1987 HANNOVER: Istituto Italiano di Cultura
1987 TRENTO: Festival Musica da Film, Sala Società Filarmonica
1987 SANREMO: Cinema Tabarin
1988 BRUXELLES: Semaine du Dessin Animèe, Palais des Congrés de Bruxelles
1988 FIESOLE: Maestri del Cinema per Ingmar Bergman
1988 ROMA: David di Donatello, Palazzo Quirinale
1988 STUTTGARD: Landesbildestelle
1988 KOELN: Kino Archiv
1988 BIELEFELD: Neues Rathaus
1989 MERANO: Teatro Puccini
1989 TRIESTE: Civico Museo Sartorio
1989 ROMA: Ambasciata di Francia, Palazzo Farnese
1989 PALERMO: Museo Internazionale delle Marionette
1989 MILANO: Teatro dei Filodrammatici
1989 AMSTERDAM: Nederlands Filmuseum
1990 BARCELLONA: Museo della Tecnica e Scienza di Catalogna
1990 ISTANBUL: Istituto Italiano di Cultura
1992 VENEZIA: Carnevale di Venezia, Teatro a l’Avogaria
1992 MOSKOW: Kino Museum e Istituto Italiano di Cultura
1994 MADRID: Istituto Italiano di Cultura
1995 ZURIG: Istituto Italiano di Cultura
1995 BERNA: Kunst Museum
1995 SINGAPORE: International Film Festival, Jubilee Hall
1995 LISBOA: Festival de Cinema, Casa de Imprença
1995 PARIS: Teatre du Musée d’Orsay
1995 HUELVA: Festival de Cine Iberoamericano, Conservatorio Superior de Mùsica Victoria Eugenia
1995 GRANADA, MONTRIL, SEVILLA: Istituti Italiani di Cultura
1995 BOLZANO: Teatro Comunale
1995 ROMA: Liceo Visconti Ex Collegio Romano
1996 PARIS: Teatre du Musée d’Orsay
1996 TELLURIDE: Telluride Film Festival
1996 ROCHESTER: George Eastman House
1997 HELSINKI: Heureka Finnish Science Centre
1998 WASHINGTON DC: Library of Congres, International Congress Domitor
1998 CLEVELAND: Convention Magic Lantern Society USA & Canada
2000 GIRONA: Museo del Cinema – Collezione Tomàs Mallol
2000 BILBAO: Zorionak Bilbao
2000 OSAKA: National Museum of Ethnology
2001 PARMA: Celebrazioni Verdiane, Ridotto del Teatro Regio
2001 SANTANDER: Memorias de la Mirada, Villa Iris
2002 GUADALAJARA: Centro de la Fotografia y le Imagen Historica
2003 TAORMINA: Taormina Arte, Palazzo dei Congressi
2003 PARIS: Auditorium du Musée du Louvre
2005 BASSANO: Musei Civici, La Notte dei Musei
2006 ROMA: Ministero Beni Culturali, Settimana della Cultura
2007 GENOVA: International Convention: Dickens and Victorian Culture
2007 PARIS: Auditorium Musée D’Orsay
2009 PARIS: Cinematheque française: Lanterne Magique et Film Peint
2010 TORINO: Museo Nazionale del Cinema: 400 Anni di Cinema
2010 PORDENONE: XXIX Giornate del Cinema Muto, Teatro Verdi